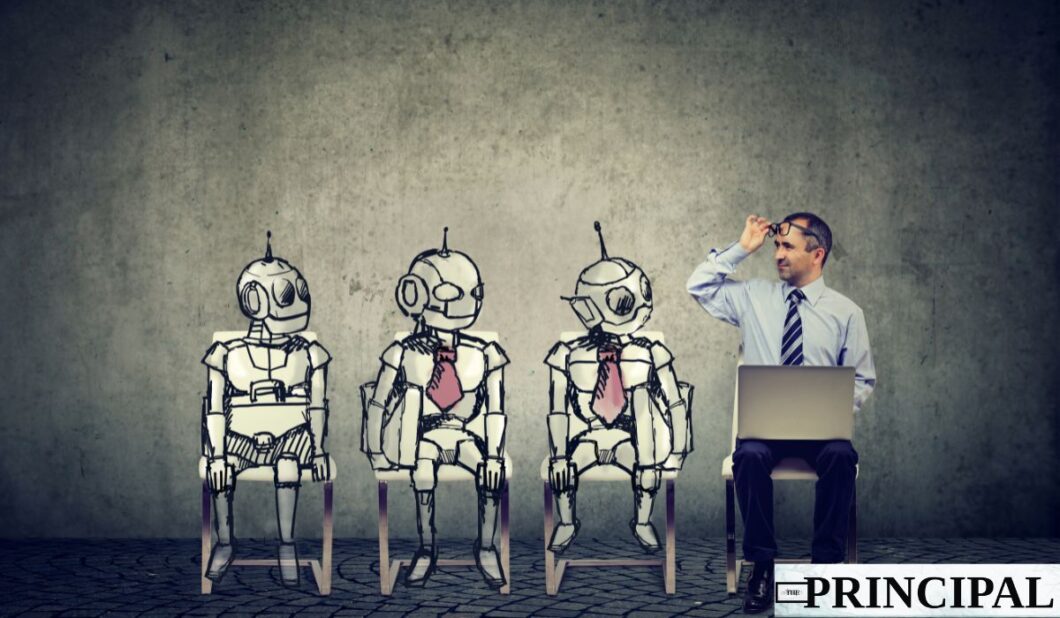Di notte faccio un sogno ricorrente – e scabroso: inserire all’interno del regolamento d’istituto della mia scuola “Vietato l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a scuola”. Potrei inserirlo proprio accanto a “Vietato l’utilizzo del cellulare a scuola”, regola che nessuno rispetta dal 2010, circa. Poi mi sveglio, mi faccio un caffè e mentre mi guardo allo specchio mi mando affanculo da solo.
Sono un pigro senza giustificazioni.
“Sorridi al nuovo che avanza! C’hai 40 anni, mica 80!” E sorridiamo allora. Cazzo.
Table of Contents
Stessa storia (“stesso posto, stesso bar…”)
“Con Wikipedia non studiano più sui libri!”
Mai sentito eh? Stessa storia? Forse. Può essere.
Certo è che se Wikipedia e Google prima ti davano solo le informazioni, oggi ChatGPT, Claude, Gemini (questi i 3 principali “super-computer” ad oggi agosto 2025) te le elaborano, te le spiegano, te le personalizzano.
Ripetizioni al pomeriggio con uno sbarbatello che studia all’università e ti piglia 15€ all’ora? Anche no grazie. ChatGPT ti costa 20€ al mese e non ti rompe le palle se un giorno non hai voglia di andare a lezione.
Dai, e poi è successo sempre per qualsiasi introduzione tecnologica a scuola. Dal calamaio alla penna biro – nessuno saprà più scrivere – dal regolo alla calcolatrice – nessuno saprà più fare contare – dalle ricerche in biblioteca a Google – nessuno saprà più studiare.
E ora è da Google all’intelligenza artificiale. Nessuno saprà più PENSARE…
Ma quindi è un male o un bene l’intelligenza artificiale a scuola?
Lo sai già: è una domanda del cazzo.
Il vero problema dell’intelligenza artificiale a scuola
Il problema non è che gli studenti usano l’intelligenza artificiale a scuola. Il problema è far finta che non la usino.
Cioè la vera questione, come sempre, è la pigrizia di noi adulti – presidi e docenti – che vorremmo che tutto rimanesse come prima, così da non sbatterci a ripensare quello che proponiamo in classe. È più facile lamentarsi che ChatGPT rovina le GIOVINE MENTI piuttosto che ammettere che forse dare come compito “Scrivi un riassunto di 500 parole sul concetto di pessimismo leopardiano” nel 2025 ha la stessa utilità di far copiare a mano l’enciclopedia Treccani.
Molto più comodo dire – come sempre – “ai miei tempi si studiava sul serio” mentre ignoriamo il fatto che “ai nostri tempi” (per me i “grungenti” anni 90!!!) non esisteva uno strumento che in 30 secondi ti faceva capire il pessimismo leopardiano meglio di come riuscivamo noi dopo tre ore di studio matto e disperatissimo. E soprattutto meglio di come lo faceva il prof.
E così eccoci a fingere che il problema sia l’intelligenza artificiale quando il vero problema è che ci siamo innamorati di un modo di fare scuola che andava bene quando l’informazione più veloce che potevi ottenere era chiamare tua cugina che aveva fatto il classico per chiederle come si traduceva la versione di latino.
Meglio mettersela via: se io fossi uno studente oggi, userei ChatGPT, Claude e Gemini per scuola. Sicuramente li userei meglio di come li uso adesso da dirigente scolastico il cui prompt principale è “aiutami a rispondere a questa e-mail senza mandare aff**** a quel paese il mittente”.
I numeri, tanto per essere chiari: il 65% degli studenti italiani tra i 16 e i 18 anni usa ChatGPT per fare i compiti. Questo circa un anno fa. A naso… saremo arrivati all’85% adesso, agosto 2025? Nel frattempo, il Ministero sperimenta l’IA in 15 scuole.
Ok.
Personalizzare l’apprendimento. Sul serio
Da decenni i professori universitari di scienze della formazione, la maggior parte dei quali non ha mai messo a piede a scuola dopo la maturità (dai non prendetevela, si fa per ridere…), martellano i futuri docenti con il concetto – sacrosanto – di PERSONALIZZAZIONE DELL’APPRENDIMENTO.
Che roba è? Risposta semplice, chiedilo a Claude:
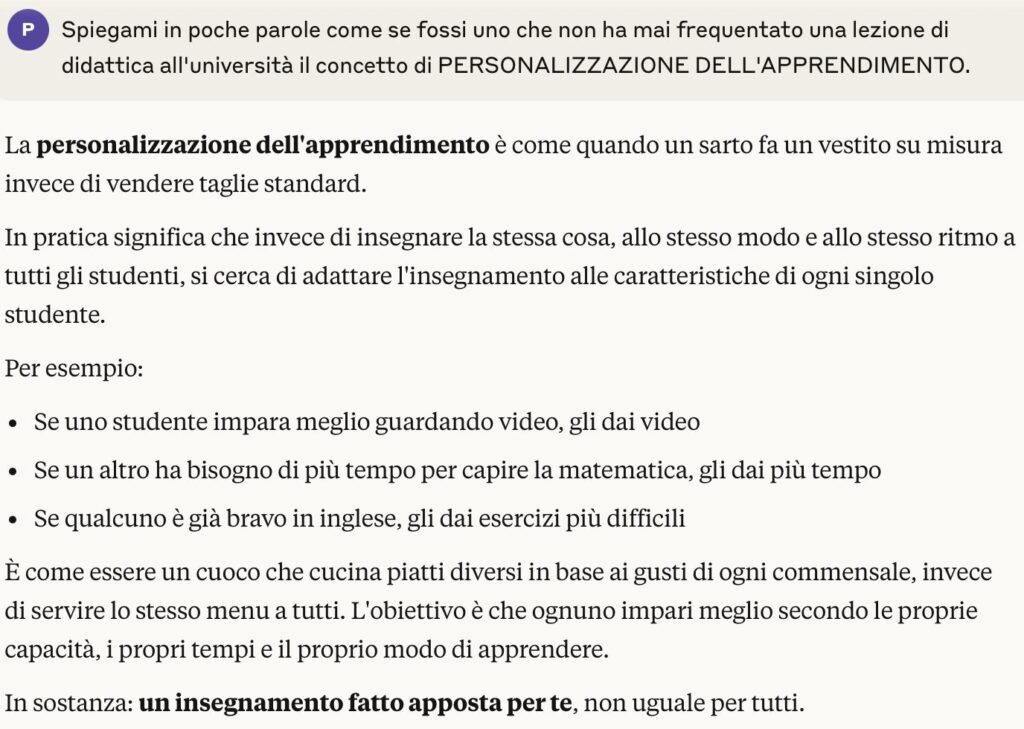
Sintetico ma sostanzialmente corretto. Bella anche la metafora del sarto e del cuoco. Poco originale, ma fuzionale. Bravo Claudio. O Claudia. Insomma, vedi tu.
In ogni caso se vuoi qualcosa in più e link per approfondire (bastava comunque continuare ad interagire con Claude), leggi l’articolo su Wikipedia.
Ora, se non sei docente immagina che per decenni noi educatori ci sentiamo ripetere questo sacrosanto principio da tutti, soprattutto, come sempre, da chi in classe non c’è mai entrato. Perché: mi spieghi cosa cazzo significa personalizzare l’apprendimento quando davanti alla tua cattedra hai 20-25 esseri umani, bocca spalancata e lingua di fuori, ognuno con il suo diverso bisogno formativo?
Però noi manteniamo dritta la barra, e nei consigli di classe ci prendiamo in giro elaborando approfonditi PDP, Piani Didattici Personalizzati per gli alunni senza disabilità e magari anche senza certificazioni di DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), ma con bisogni educativi speciali. E in cosa consistono questi PDP, in concreto? Misure compensative, tipo calcolatrice durante il compito di matematica, 20 minuti in più per scrivere il tema, mappe concettuali per la verifica di geografia etc o, dispensative, come la dispensa da alcune prove o addirittura materie, dispensa dal lavoro di copiatura, dispensa dalla lettura ad alta voce, dispensa dallo studio mnemonico etc.
Ma questo non è personalizzare l’apprendimento. Personalizzare è seguire tutti quei bei consigli che ci vengono scritti in calce alle certificazioni – pardon, diagnosi! – degli psicologi privati. Ne cito alcuni, tra le diagnosi che ho ora tra le mani:
- osservare come lo studente apprende più facilmente: se attraverso immagini, suoni, movimento o toccando le cose;
- identificare i punti di forza: magari uno è bravo con i numeri ma ha difficoltà con la lettura;
- capire i tempi di ciascuno: alcuni studenti hanno bisogno di più tempo per elaborare le informazioni;
- usare supporti visivi: mappe concettuali, disegni, colori per chi impara meglio guardando;
- spezzettare i compiti: invece di dare un esercizio lungo, dividerlo in piccoli pezzi;
- creare routine: strutture fisse che diano sicurezza;
- ridurre le distrazioni: posto tranquillo, senza troppi rumori o stimoli visivi;
- pause frequenti: permettere di riposare la mente ogni 15-20 minuti;
- celebrare i piccoli progressi: riconoscere ogni miglioramento, anche minimo
- etc etc etc.
Eh già.
IA e Flipped classroom
Ok, e quindi cosa ci faccio co sta intelligenza artificiale a scuola?
Possiamo farci quello che dovremmo fare da sempre: una volta per tutte trasformiamo la classe nel posto dove si lavora attivamente sulle informazioni, non dove si ricevono passivamente.
Un’idea tra le tante: attuiamo sta benedetta FLIPPED CLASSROOM: qui la pagina di Indire sulla Flipped Classroom, qui l‘articolo di Wikipedia.
Parliamoci chiaro: quella che oggi chiamiamo “flipped classroom” – classe capovolta – o “flipped learning” – insegnamento capovolto – non è una scoperta dell’era ChatGPT. Esiste da almeno vent’anni e funziona così: introduci i concetti della lezione prima di entrare in classe (solitamente a casa, online), per poi utilizzare il tempo in aula per lavorarci su quelle informazioni, con attività pratiche e innovative, guidando ogni studente attraverso l’applicazione di quello che ha studiato a casa.
Aspetta, te lo spiega meglio Claude.
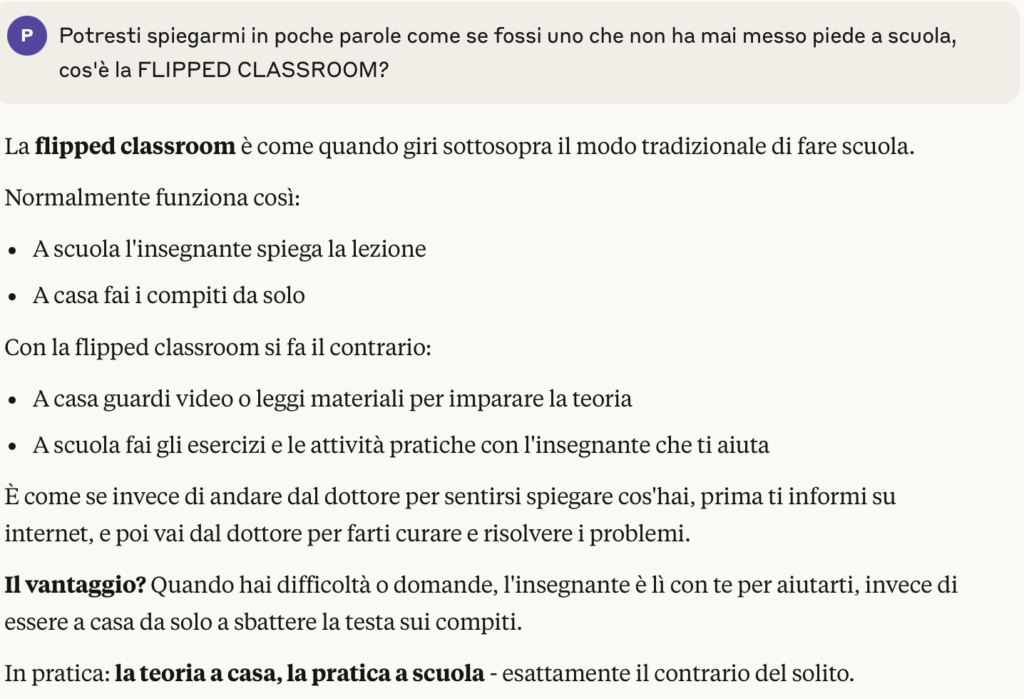
Va beh, tralasciando la parte sull’autodiagnosi a casa… Rivoluzionario, eh? Non so se è rivoluzionario, a me sembra buon senso.
Ma buon senso o meno, la flipped classroom funziona? Ecco la risposta che fa incazzare sempre tutti quelli che vorrebbero un mondo fatto in bianco o nero: DIPENDE. Fino ad oggi l’entusiasmo per la flipped classroom non è sempre stato supportato da prove scientifiche robuste. In questo studio “Fail, flip, fix, and feed – Rethinking flipped learning: A review of meta-analyses and a subsequent meta-analysis” di Kapur, Hattie, Grossman e Sinha (2022), ad esempio gli autori dimostrano che la flipped classroom ha perpetuato l’apprendimento passivo anziché ridurlo, soprattutto in presenza di materiale passivo da studiare a casa. Partendo da qui tra l’altro gli autori dell’articolo teorizzano un nuovo “modello” di apprendimento in 4 fasi: fail, flip, fix, feed. Da approfondire.
E allora cosa cambierebbe oggi con l’intelligenza artificiale? Un po’ di robette, suggerite da quest’altro articolo “Flipped Learning and Artificial Intelligence” di López-Villanueva, Santiago e Palau (2024):
- l’integrazione dell’IA può promuove l’apprendimento adattivo, dove l’IA genera versioni diverse dello stesso materiale adattandosi alle competenze e conoscenze pregresse degli studenti;
- L’IA può automatizzare la creazione di materiali didattici (video, simulazioni interattive, esami, guide allo studio), liberando tempo agli insegnanti per concentrarsi sulla progettazione delle esperienze di apprendimento in classe;
- L’IA può stimolare il pensiero critico, la creatività e la risoluzione dei problemi, sfidando gli studenti a formulare domande e a impegnarsi in un apprendimento più profondo (Maieutica scansati);
- l’IA può superare alcuni bisogni educativi speciali, ad es. descrivendo immagini in testo/audio per studenti ciechi o facilitando la traduzione di contenuti in diverse lingue etc;
- l’IA permette l’automonitoraggio continuo dei progressi degli studenti, rilevando punti di forza e debolezza ed eventualmente prevedendo anche le future prestazioni in un compito in classe.
Esempio scemo
Facciamo un esempio concreto. Materia: storia. Argomento: la Rivoluzione Francese.
Metodo tradizionale:
- In classe: il prof spiega cause, eventi, conseguenze;
- A casa: gli studenti studiano sul libro e fanno una ricerca su Robespierre;
- Verifica: domande su date, nomi, eventi.
Metodo flipped con IA:
- A casa: gli studenti usano libro (o video, o podcast o quello che vuoi tu) + ChatGPT per capire cause, eventi, conseguenze. L’IA può spiegare concetti difficili, fare esempi, rispondere a dubbi specifici di ciascuno studente o fornire ulteriore materiale di approndondimento;
- In classe: si discute se la Rivoluzione era inevitabile, si confrontano le fonti storiche, si analizzano i documenti dell’epoca, si fa un dibattito tra girondini e giacobini;
- Verifica: analisi di fonte storica + riflessione critica sulle conseguenze.
Sfide (che palle!)
Inutile dire che, come sempre, bisogna scontrarsi con sfide importanti per utilizzare l’intelligenza artificiale a scuola.
Le elenca, secondo me molto precisamente, l’articolo di López-Villanueva, Santiago e Palau (2024), linkato sopra:
- Accuratezza delle informazioni e necessità di revisione umana: bisogna fare attenzione all’accuratezza delle risposte fornite dall’IA. Per questo sarebbe necessario convalidare le informazioni da parte degli insegnanti, che dovrebbero in primis capire il funzionamento dell’IA (formazione, formazione, formazione);
- Dipendenza: esiste il concreto rischio di una dipendenza eccessiva dall’IA, che potrebbe essere usata esclusivamente per sostituire lo sforzo della nostra, ormai ne è rimasta poca, materia grigia;
- Competenza nella formulazione dei “prompt”: la capacità di formulare istruzioni efficaci (prompt) è essenziale per l’uso dell’IA, e la mancanza di questa competenza ne limita il potenziale;
- Barriere economiche: Il costo di alcune piattaforme potrebbe aumentare il divario tra gli studenti che provengono da un contesto economico-familiare sfortunato;
- Considerazioni etiche: privacy dei dati (che SUPER palle!) degli studenti e l’uso responsabile dei contenuti generati dall’IA.
Per approfondire
Di seguito alcuni materiali che ho letto per scrivere questo articolo e documenti, anche ufficiali, da approfondire per essere meno capre.
Prima di tutto, leggiti la Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026. Aria fritta o linee guida concrete per l’integrazione dell’IA nelle scuole, la formazione dei docenti e l’educazione civica digitale? Vedi tu.
Se sei un docente e vuoi capire come usare concretamente l’IA, INDIRE ha messo online il progetto European Digital Education Hub con una serie di PDF scaricabili che spiegano applicazioni pratiche dell’IA in classe. Roba del 2023, da aggiornare. Ma è INDIRE. Stima.
Infine i due articoli accademici che ho citato sulla flipped classroom:
- Fail, flip, fix, and feed – Rethinking flipped learning: A review of meta-analyses and a subsequent meta-analysis” di Kapur, Hattie, Grossman e Sinha (2022)
- Flipped Learning and Artificial Intelligence” di López-Villanueva, Santiago e Palau (2024)
Entrambi sono ad accesso libero, quindi non serve pagare per leggerli.
Perché ci tengo a mostrare il banner “Non Da AI”
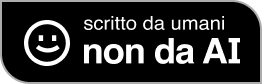
Ultima cosa. Avrai notato che questo blog ha il banner di NotByAI.fyi, cosa che ho sottolineato fin dalla prima pagina del blog, “Chi sono“. Non è una posa intellettuale o una crociata contro l’intelligenza artificiale. È semplicemente onestà.
Tutto quello che leggi qui è scritto da me, con quei due neuroni che mi sono rimasti dopo aver passato la giornata a usare Claude per scrivere l’ennesima circolare ai genitori o l’ennesimo progetto PON. Sì, certamente: uso l’IA tutti i santi giorni per la burocrazia. E continuerò a farlo.
Progetti PNRR? Scritti con l’IA. Risposte a email formali? Scritte con l’IA. Risposte a email informali? Scritte con l’IA. Comunicazioni ufficiali che nessuno leggerà mai? Scritte con l’IA. Risposte a studi legali che minacciano di denuciare la scuola (cioè me…) per qualsiasi cosa e io devo rispondere senza usare parolacce? Scritte con l’IA.
Minima spesa, massima resa. I miei studenti potranno beneficiare di tutti i finanziamenti possibili grazie al fatto che riesco a completare pratiche che altrimenti mi porterebbero via settimane. Mi sembra un buon trade-off.
Però quando scrivo per questo blog uso solo il mio cervello. Quello danneggiato, limitato, ma genuinamente mio. Perché le idee, le opinioni discutibili, gli errori e le imprecazioni che trovi qui sono frutto di esperienza diretta, non di elaborazione algoritmica. Una differenza che, almeno per ora, mi sembra ancora importante.
Se vuoi commentare o insultarmi, sfogati nei commenti.